Oggi si discute molto sulla divisione dei poteri in uno Stato democratico, per evitare derive che possano mettere a rischio le conquiste ottenute grazie al sacrificio dei nostri padri in favore delle libertà e della democrazia. Sempre più spesso si ascoltano opinioni che convergono nella difesa dei valori acquisiti, ma il dibattito sul rapporto tra potere politico e magistratura è spesso caratterizzato da una confusione di fondo: i poteri dello Stato non sono tre, bensì due. Sovente sentiamo dire che nel nostro Paese i poteri dello Stato sono tre e distinti: legislativo, giudiziario ed esecutivo. Il potere legislativo è attribuito al Parlamento, il potere esecutivo al Governo e il cosiddetto potere giudiziario alla Magistratura.
Ma è proprio così? No.
In realtà, secondo la Costituzione italiana, i poteri dello Stato sono solo due:
- Il potere legislativo, che spetta al Parlamento e consiste nella creazione delle leggi;
- Il potere esecutivo, che spetta al Governo e ha il compito di attuare e far rispettare le leggi.
E la Magistratura? Non è un vero e proprio “potere”, bensì un ordine autonomo e indipendente.
Cosa dice la Costituzione?
L’articolo 104 della Costituzione recita chiaramente:”La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.” Questa distinzione è fondamentale: la Magistratura non governa né crea leggi, ma si occupa esclusivamente di applicarle e garantire la giustizia. La sua funzione è quindi diversa rispetto ai poteri legislativo ed esecutivo.
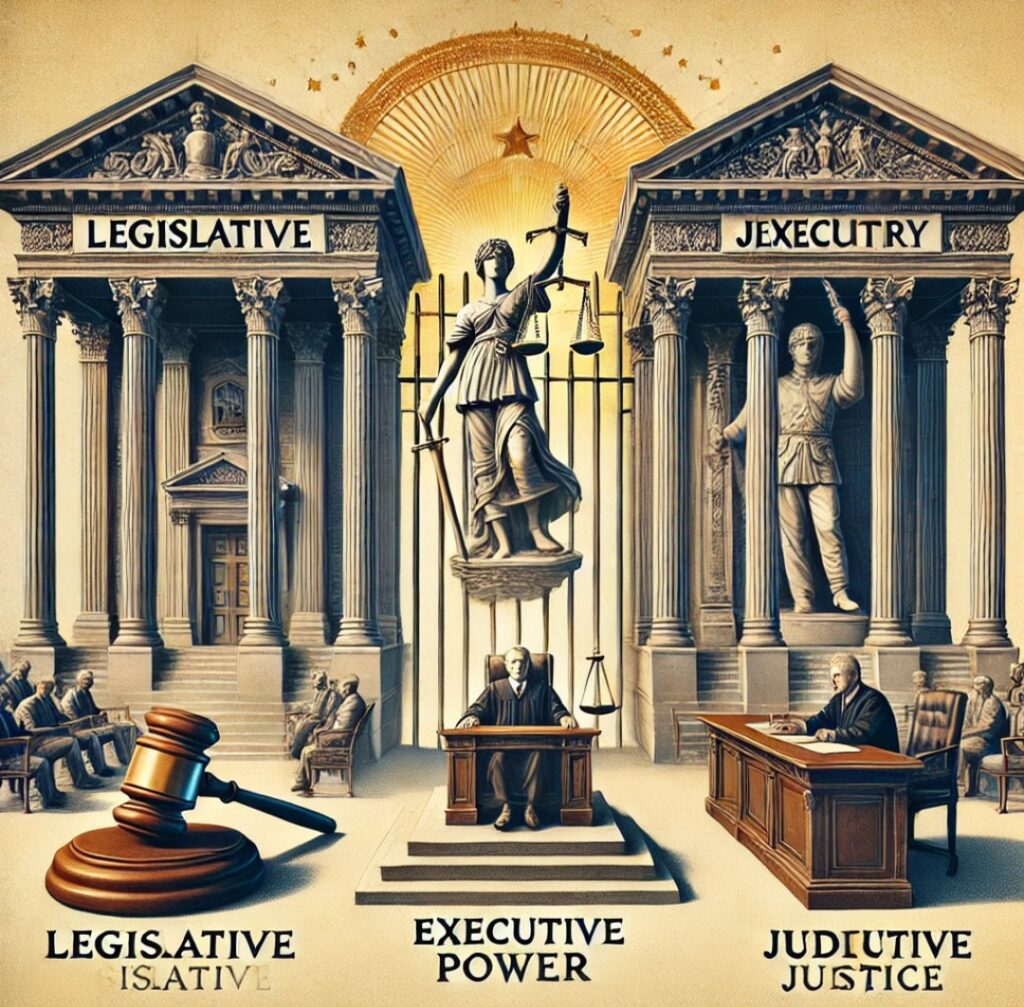
Perché la Magistratura non è un potere?
Nella teoria classica della separazione dei poteri di Montesquieu, il potere giudiziario era considerato autonomo. Tuttavia, nella Costituzione italiana, la Magistratura non viene mai chiamata “potere”, proprio perché la sua funzione non è paragonabile a quella del Parlamento o del Governo. Un “potere” implica la capacità di decidere l’indirizzo politico o di creare norme. La Magistratura, invece, non decide politicamente, ma si limita a interpretare e applicare le leggi approvate dal Parlamento.
Quali sono le conseguenze di questa distinzione? Capire che la Magistratura è un ordine e non un potere ha importanti implicazioni:
- Evita la confusione tra chi fa le leggi e chi le applica: il Parlamento legifera, la Magistratura non interviene nella creazione delle leggi.
- Ribadisce l’indipendenza della Magistratura: essa non deve subire interferenze politiche, né essere considerata alla pari degli altri due poteri.
- Chiarisce il ruolo dei giudici: essi non governano, non legiferano, ma garantiscono che le leggi siano rispettate.
Concludendo: affermare che in Italia esistono tre poteri dello Stato è impreciso. La Magistratura, infatti, non è un potere in senso proprio, ma un ordine autonomo e indipendente, distinto dai due veri poteri dello Stato riconosciuti dalla Costituzione: il legislativo, affidato al Parlamento, e l’esecutivo, esercitato dal Governo. Questa distinzione, pur sembrando sottile, è fondamentale per comprendere il funzionamento della nostra democrazia e per evitare equivoci nei dibattiti pubblici e politici. Definire la Magistratura come ordine giudiziario non ne sminuisce il ruolo, ma ne chiarisce la collocazione istituzionale: essa non legifera né governa, ma garantisce il rispetto delle leggi e la tutela dei diritti dei cittadini. La Magistratura, dunque, non è un potere politico, ma un organo di garanzia della legalità. La sua autonomia è sancita dall’articolo 101 della Costituzione, secondo cui i magistrati sono soggetti solo alla legge. Questo principio, pilastro dello Stato di diritto, deve essere sempre rispettato e salvaguardato, affinché la giustizia possa rimanere imparziale e indipendente da qualsiasi influenza esterna ( Francesco Garofalo- docente di Sociologia e Storia delle Istituzioni politiche)
